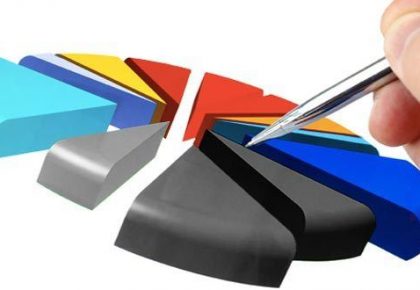Fra meno di due settimane, senza troppa pubblicità, la Fed discuterà in un convegno l’adozione di un nuovo obiettivo di inflazione. Non più un obiettivo annuale, da tempo il due per cento, ma un obiettivo medio di lungo periodo, sempre del due per cento. La differenza? Nel primo caso ogni anno si ricomincia da capo e, se l’anno precedente l’inflazione è stata, poniamo, dell’1.5, l’anno seguente avrà comunque il due come obiettivo. Nel secondo caso, invece, se nei dieci anni precedenti l’inflazione effettiva è stata dell’1.5 per cento, nei prossimi dieci, per compensare, dovrà essere del 2.5.
È un modo per alzare l’obiettivo di inflazione (o la tolleranza verso l’inflazione) senza dire di farlo. Formalmente il due per cento resta in vigore e gli si rende anzi ulteriore omaggio cercando di rispettarlo a tutti i costi, anche retroattivamente. In pratica, per i prossimi dieci anni il 2.5 è il nuovo due.
Per rendere ancora più morbido il passaggio di regime, questo nuovo obiettivo, che verrà sicuramente adottato visto che tutti gli esponenti della Fed che ne hanno finora parlato si sono detti favorevoli, l’entrata in vigore verrà rimandata al 2020.
Proviamo ora a mettere insieme i pezzi del puzzle. La Fed vuole più inflazione. La Brainard, autorevole esponente del Fomc, si dice aperta a un targeting dei tassi della parte breve media in modo da mantenerli fermi su un certo livello. Alcuni dei principali indici d’inflazione, come il PCE adottato ufficialmente dalla Fed, sottovalutano in modo aperto l’inflazione (l’inflazione sanitaria, ad esempio, è calcolata sulla base dei rimborsi che il governo concede ai medici di Medicare, non su quello che pagano davvero i pazienti, mentre il prezzo delle case viene ricavato tortuosamente dagli affitti). Il Fomc, nel verbale comunicato ieri, intende mantenere i tassi fermi per parecchi mesi ancora.
Ecco, proprio questa decisione sui tassi fermi ha deluso il mercato azionario, che attende invece almeno un ribasso per fine anno. Se però si mettono insieme i tassi fermi con l’inflazione che sale di mezzo punto negli obiettivi di policy, abbiamo comunque una riduzione di mezzo punto dei tassi reali. In pratica, tassi reali negativi mentre siamo entrati nell’undicesimo anno di espansione ciclica. In altre parole, una politica monetaria espansiva in una fase in cui, sulla base dell’esperienza storica, dovrebbe essere almeno moderatamente restrittiva, considerando anche il pieno impiego raggiunto dal mercato del lavoro.
Ora supponiamo che l’inflazione, in un futuro non troppo lontano, scappi di mano e arrivi al tre, quando l’obiettivo di fatto è il 2.5.
Ci possono essere due risposte, tra di loro ben diverse.
Il mercato può perdere fiducia nella sincerità della Fed, passata con un gioco di prestigio dal due al 2.5 e che si vede servito, in ipotesi, il tre. Considerando che il debito pubblico americano l’anno scorso è cresciuto del 6 per cento (il disavanzo è stato del 4.5, ma il debito, che include tutte le spese fuori bilancio, è salito del 6) e che nei prossimi anni continuerà a crescere a ritmi molto sostenuti, il mercato potrebbe mettersi a chiedere quello che ha avuto per cinquemila anni prima del 2008, ovvero tassi reali positivi, e quindi un dieci anni che va a rendimenti del 4 per cento e poi chissà.
La seconda risposta è che, essendo bastate nei mesi scorsi poche settimane di rendimenti sopra il tre per scatenare il finimondo e fare temere una recessione, e tenendo conto del fatto che né Trump né un suo eventuale successore democratico vogliono trovarsi in una recessione molto rischiosa, allora è possibile che i policy maker decidano di sopprimere il mercato e di imporre tassi decisi a tavolino. Come sarebbero questi tassi? Come gli attuali, se la Fed decide di fare finta di niente, o addirittura più bassi se il successore di Trump sarà un democratico radicale con simpatie MMT (ricordiamo che la MMT teorizza i tassi permanentemente a zero).
Insomma, come ha notato Jeffrey Gundlach in un recente e brillante dibattito con l’ex Fed Danielle DiMartino Booth (su YouTube), ci troviamo in una Twilight Zone, ovvero ai confini di una realtà in cui i tassi potrebbero essere a zero o al quattro con le stesse condizioni sottostanti. Un po’ come il gatto di Schrodinger, quello vivo e morto allo stesso tempo.
I mercati, nel dubbio, stanno giustamente a metà strada, in attesa di capire. È un’attesa che in America apparentemente non costa, dal momento che tassi e inflazione sono uguali (anche se sui tassi si pagano imposte). In Europa e in Giappone, dove i tassi resteranno a zero per tutto l’orizzonte prevedibile, l’eutanasia del rentier, già in corso da dieci anni, verrà accelerata. Certo, l’obbligazionista europeo ha avuto qualche anno di capital gain sui bond che aveva comprato prima del 2008, ma da qui in avanti i capital gain ci saranno solo se i tassi da negativi diventeranno profondamente negativi. In altre parole, ci saranno capital gain solo per gli audaci che si comprano decennali tedeschi (pagando alla Germania un interesse dello 0.12 annuo e chiudendo un occhio sull’inflazione tedesca al due tondo) se i tassi diventeranno ancora più negativi. Per tutti gli altri, nell’area euro, l’unico modo per sopravvivere sarà andare a prendersi rischi.
Questo ci porta a pensare che l’azionario, pur non avendo più davanti a sé orizzonti particolarmente luminosi, abbia sotto di sé un sostegno rappresentato dalla mancanza di alternative particolarmente attraenti.
Venendo al breve termine, puntuali come un cronometro, le chiacchiere di aprile sul meltup, le teorie sull’accelerazione del rialzo che spuntano dopo mesi di rialzo ininterrotto, hanno coinciso con l’inizio della correzione in corso.
Certo, c’è stata nel frattempo la caduta di uno dei due pilastri su cui si era retto il rimbalzo iniziato a Natale, ovvero l’apparente distensione tra Stati Uniti e Cina. L’altro pilastro, la Fed non più restrittiva, rimane però saldo, come abbiamo visto, ed è alla fine più importante del primo.