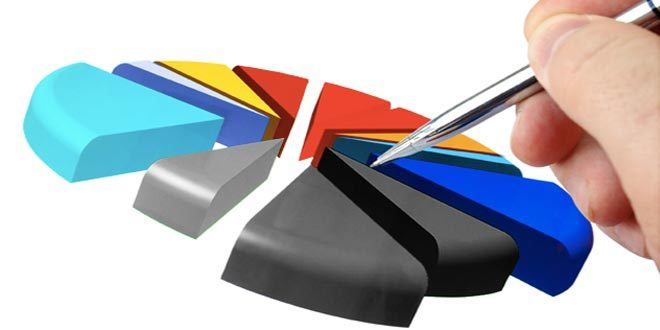
Come fanno spesso notare gli animalisti, uomini e scimpanzé condividono il 98.8 per cento del loro patrimonio genetico. Questa e altre statistiche (abbiamo in comune il 60 per cento dei geni perfino con le banane, per non parlare degli scarafaggi, che hanno il nostro stesso identico grado di complessità) vengono spesso evocate per ridimensionare la presunzione di unicità di molte culture umane e per richiamarci ai doveri di fratellanza verso tutte le creature.
E tuttavia, come nota sconsolato Richard Wrangham, primatologo di Harvard e scrittore affascinante, se chiudessimo in un aereo 800 scimpanzé che non si conoscono tra loro per un volo intercontinentale, all’arrivo troveremmo decine di morti, vittime delle risse furibonde che inizierebbero già prima del decollo per stabilire chi è il maschio alfa e chi sono tutti gli altri. A noi umani l’aggressività di questi animali appare davvero straordinaria. Il maschio alfa è quello che ha picchiato tutte le femmine e tutti gli altri maschi. Ogni maschio avrà figli dalla femmina che si è lasciata picchiare di più e così via.
Il sogno di tutti i maschi beta, osserva Wrangham, è quello di uccidere il maschio alfa. Non avendo il linguaggio, tuttavia, gli scimpanzé beta non sono capaci di organizzarsi. Gli uomini invece lo sono e anche nelle culture più primitive il tirannicidio è pratica corrente che di fatto obbliga tutti, sovrano incluso, a seguire delle regole, che verranno poi razionalizzate in un sistema etico. In questo Wrangham ricorda alla lontana René Girard e la sua teoria dell’uccisione del capo (che si è precedentemente adorato e seguito) come rito fondativo di tutte le civiltà. È dal tirannicidio, conclude Wrangham, che parte il processo di autodomesticazione dell’uomo, che ha come effetti collaterali la diminuzione progressiva di aggressività, l’infantilizzazione e il rimpicciolimento costante del volume del nostro cervello, destinato a continuare in futuro.
Che siamo simili, ma non identici, ce lo dice anche la biometrica. Nemmeno i gemelli omozigoti hanno le stesse impronte digitali. Iride e retina sono sempre diverse. E anche se abbiamo l’età per avere imparato a scrivere nelle scuole in cui si insegnava un corsivo uguale per tutti, nessuno di noi ha la stessa grafia di un altro essere umano. E noi stessi, clonati, saremmo comunque differenti perché faremmo esperienze diverse.
Chi ha fatto meglio sui mercati azionari, in questo 2019, è stato chi ha usato il template del 2016. Quella del gennaio-febbraio 2016 e quella dell’ottobre-dicembre 2018 appaiono crisi molto simili. Entrambe sono il risultato di un posizionamento sbilanciato al rialzo che si scontra con un brusco rallentamento della crescita (ma non con una recessione conclamata) che si rivela poi meno grave del temuto. In entrambi i casi la Cina ha un ruolo negativo importante, nel 2016 per effetto della fuga di capitali e oggi per le sanzioni commerciali americane. E simile appare lo spiazzamento della Fed, che rinuncia in ritardo alle sue aspirazioni restrittive.
Molto simili sono anche le reazioni delle imprese, che per prudenza corrono ad abbassare le stime sui loro utili, e quelle degli analisti azionari, che durante una crisi tagliano in modo lineare le loro proiezioni su tutte le società che seguono. Ecco allora che si apre una fase di divergenza (marzo 2016, gennaio 2019), con da una parte le borse che intuiscono la fine della crisi e iniziano a muoversi al rialzo mentre dall’altra gli analisti continuano ad abbassare le stime e a fornire ai pessimisti un alibi perfetto per non comprare e per perdersi un travolgente recupero del mercato.
Per concludere con le somiglianze, le due crisi traumatizzano le banche centrali, che rimangono paralizzate molto a lungo prima di riprendere l’iniziativa. In questa paralisi, nei due casi, entra poi una componente politica. Nel 2016 una Fed democratica rinuncia ad alzare i tassi per favorire la Clinton, mentre nel 2019 una Fed repubblicana con velleità di indipendenza subisce comunque il cannoneggiamento quotidiano di un Trump che si candida alla rielezione.
Nota Mislav Matejka, uno strategist spesso capace di andare controcorrente con successo, che nel 2016 le stime degli analisti continuarono a essere tagliate fino all’autunno, quando la borsa era già ripartita da sei mesi e avrebbe proseguito il suo rialzo solido e costante fino al gennaio 2018. Da qui l’idea, che Matejka sviluppa in un report di 150 pagine per JP Morgan, di continuare a stare nel mercato, incrementando le posizioni se gli utili del primo trimestre dovessero provocare un assestamento.
Altri, invece di rendere omaggio al 2016, propongono di ispirarsi al 2018, un anno di fluttuazioni ampie ma non estreme e non limitano questo andamento sostanzialmente laterale al 2019, ma lo estendono a una buona parte del prossimo decennio.
Noi siamo disposti ad adottare il template del 2016 fin quasi alla fine del 2019. Certo, la riaccelerazione della crescita dopo il momento di arresto, che nel 2016 fu rapida, questa volta si profila lenta e faticosa. In compenso i tassi sul Treasury decennale, che dall’agosto al dicembre 2016 si portarono dall’1.50 al 2.50, questa volta rimarranno molto più tranquilli.
C’è però una differenza, tra oggi e tre anni fa, che adesso può apparire non significativa, ma che con il passare dei mesi diventerà più visibile. Il 2016 si chiude con Trump presidente eletto. Guardando all’anno successivo, il mercato può intravvedere un grosso taglio delle tasse e una rilevante deregulation. Quando però, alla fine del 2019, getteremo uno sguardo sul 2020, vedremo una battaglia campale tra un Trump che vorrà spingere al massimo economia e borse e candidati democratici che faranno a gara nel proporre tasse più alte, limiti ai buy-back e reregulation. Tra loro, in mezzo, ci sarà un ciclo ancora più vecchio. Sarà molto difficile destreggiarsi in quel contesto, che immaginiamo volatile come i sondaggi, e lo smart money vorrà probabilmente alleggerirsi prima di affrontarlo.
Nessun anno è uguale all’altro.


