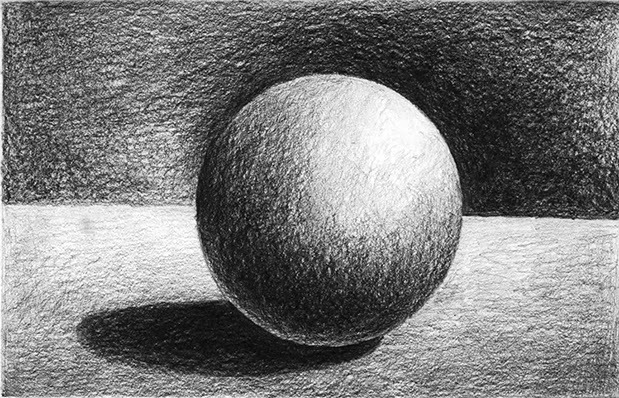
Felicità, per i mercantilisti, è esportare. Più precisamente è esportare il più possibile e importare il meno possibile, in modo da realizzare ogni anno un attivo delle partite correnti che vada a sommarsi a quello degli anni precedenti. Questo tesoro, accumulato nel tempo, fino a mezzo secolo fa era costituito da oro e da valute estere convertibili in oro. Oggi, più prosaicamente, è costituito quasi esclusivamente da carta elettronica emessa da banche centrali straniere.
Contemplare il proprio tesoro piace a molti, ma anche per un mercantilista la contemplazione pura di lingotti d’oro o di titoli di stato stranieri è una forma di feticismo. La motivazione razionale, per lui, è quella di avere un apparato produttivo imponente e competitivo. Imponente, perché deve cercare di soddisfare non solo la domanda interna, ma anche quella estera, che è potenzialmente molto più grande. Competitivo, perché altrimenti, nel lungo periodo, altri paesi prenderanno il suo posto.
Certo, un mercato estero di sbocco può essere conquistato con mezzi militari, così come un mercato interno può essere difeso con alti dazi. Storicamente è stato così per tutti gli imperi coloniali. Le colonie compravano i manufatti della madrepatria non perché questa avesse i prodotti migliori a un prezzo più basso, ma perché erano gli unici che era loro consentito acquistare. Quando però le spese militari per controllare le colonie cominciarono a salire oltre un certo livello, gli imperi dovettero essere abbandonati. A quel punto, laddove non entravano in funzione meccanismi neocoloniali, i prodotti della madrepatria, se non competitivi, perdevano il mercato di sbocco.
Dal canto loro gli alti dazi per difendere il mercato interno, se protratti nel tempo, impigriscono i produttori domestici. Per questo il mercantilista intelligente, a partire dal momento in cui si sente competitivo e sicuro di sé, si schiera a favore del libero scambio.
Il mercantilismo del secondo dopoguerra è stato concesso dal vincitore, gli Stati Uniti, ai vinti, Giappone e Germania. Con un dollaro sopravvalutato rispetto a marco e yen e la disponibilità ad accettare dazi asimmetrici, l’America ha accelerato la ricostruzione dei paesi sconfitti e, dando loro benessere, li ha tenuti lontani dalla tentazione di avvicinarsi troppo all’Unione Sovietica.
Anche il mercantilismo cinese è octroyé, è cioè, in origine, una concessione dell’Occidente alla Cina di Deng. L’Occidente permette alla Cina di mantenere un renminbi sottovalutato e di adottare pratiche commerciali disinvolte per accelerare la costruzione di una forte economia. L’obiettivo politico (finora mancato) è quello di una Cina assimilata al modello liberaldemocratico. L’obiettivo economico (mancato a metà) è quello di avere nel tempo un vorace compratore di prodotti di un Occidente che ha saturato il suo mercato interno.
Tutto questo funziona bene nei primi decenni, ma nel tempo gli effetti collaterali si moltiplicano. Il mercantilismo di Giappone, Germania e Cina diventa patologico. Secondo la Banca Mondiale le esportazioni tedesche nel 1970 (quando la Germania aveva completato da un pezzo la sua ricostruzione e non aveva più bisogno di particolari sostegni esterni) costituivano il 16 per cento del Pil, oggi sono il 48 per cento. Naturalmente sono aumentate anche le importazioni, ma il saldo attivo delle partite correnti non è mai stato così alto come oggi.
Il mercantilismo giapponese è stato stroncato con durezza nella seconda metà degli anni Ottanta, quando un’America spaventata e inferocita ha imposto una gigantesca rivalutazione dello yen la cui eco arriva fino a oggi. Germania e Cina, considerate meno pericolose tecnologicamente del Giappone del 1985, sono state lasciate tranquille fino a Trump.
La patologia del mercantilismo si manifesta oggi in vari modi. Uno di questi è la tendenza a mantenere compressa la domanda interna o con un cambio sottovalutato (Germania) o con bassi salari (la Cina fino ai primi anni Duemila). Negli ultimi due decenni la Cina ha in parte corretto questa distorsione alzando i salari reali, ma ha mantenuto una politica di welfare minimo che obbliga i cinesi a risparmiare molto e continua quindi a deprimere la domanda interna.
Un altro aspetto sempre più patologico è la tendenza cinese, evidente nella nuova via della seta, verso forme di conquista di mercati esteri inizialmente morbide, ma poi sempre più soffocanti. Che cosa c’è di più bello, per un Kenya o per un Pakistan, che ricevere chiavi in mano centrali nucleari o ferrovie ad alta velocità totalmente finanziate da prestiti cinesi? Il problema è che poi arriva il conto da pagare. Se non ci sono i soldi si scopre, leggendo le parti del contratto scritte in piccolo, che bisogna cedere alla Cina la propria rete elettrica o magari un porto, che i cinesi potranno trasformare in base militare per la loro marina.
Se il Giappone si è adattato faticosamente a un modello postmercantilista, per Cina e Germania i guai sono iniziati da poco, ma la transizione rischia di essere altrettanto impegnativa.
Per la Cina, che è da mesi in marcato rallentamento, i mercati scommettono su un accordo non troppo penalizzante con l’America nelle prossime settimane. Trump ha bisogno di un successo e la Cina è pronta a parecchie concessioni. Sulle questioni strategiche, in primo luogo la tecnologia, il conflitto rimarrà però latente a lungo e si riaprirà verosimilmente nei prossimi anni. Stiamo vedendo con Huawei quanto può essere distruttiva la potenza di fuoco occidentale.
La Cina, d’altra parte, andrà incontro a difficoltà crescenti nella sua espansione in Asia, in Africa e in America Latina. I governi di questi paesi accetteranno i doni cinesi solo se disperati e alla fine faranno default sui loro debiti con Pechino. Certo, la Cina si costruirà una rete di basi navali, ma a costi crescenti economici e politici.
La Germania, dal canto suo, sembra non avere compreso a fondo la complessità della sua situazione. Nel momento in cui i mercati esteri si chiudono o diventano comunque meno profittevoli sarebbe utile avere a disposizione un mercato interno (l’Unione europea) prospero e ricettivo. È la stessa Germania, tuttavia, ad avere imposto in questi anni a tutto il continente un modello di deflazione salariale e di compressione della domanda interna. Ed è sempre la Germania a tenere di fatto bloccata la politica fiscale dell’eurozona, che deve essere sempre Basi commerciali straniere a Canton. 1820. restrittiva e mai espansiva.
Quelli di cui abbiamo parlato fin qui sono problemi strutturali. Non si manifesteranno tutti subito e verranno comunque mitigati in un modo o nell’altro. La politica fiscale europea, ad esempio, è già meno restrittiva per effetto dell’interpretazione più creativa delle regole di bilancio in molti paesi e per la prossima adozione di misure espansive in Germania. L’Europa trarrà poi beneficio, come ha sempre fatto, dall’espansione fiscale degli altri, a partire da Cina e America.
Entro la fine di quest’anno (molto prima per la Cina) verranno poi augurabilmente raggiunti nuovi accordi commerciali con gli Stati Uniti. I mercati scontano già che siano moderatamente penalizzanti per Germania e Cina, ma la fine delle ostilità e la possibilità di lavorare in un quadro più certo per le imprese esportatrici saranno accolti con favore dalle borse e dall’euro.
Nessun accordo è garantito fino al momento della firma. Sono possibili rinvii o accordi parziali. Tuttavia, messi alle strette, tutti i protagonisti avranno interesse a trovare un punto di equilibrio.
Se così sarà (e quello di un accordo resta lo scenario di base) il 2019 avrà tre fasi distinte. La prima, in corso, è la fase americana, un prolungamento del 2018 e della borsa di New York che batte Shanghai e Francoforte. La seconda, quando e se verrà raggiunto l’accordo con la Cina, vedrà un solido rimbalzo della borsa di Shanghai, che si tirerà dietro tutta l’Asia per qualche mese. L’ultima fase, a conclusione delle trattative sulle auto tedesche (molto più semplici di quelle con la Cina), vedrà finalmente un recupero delle borse europee e dell’euro.


